Le novità che ci giungono da Copenaghen sono più sfaccettate di quanto apparirebbe ad una prima analisi. I tagli delle emissioni di gas serra annunciati non sono affatto sufficienti per controllare il riscaldamento globale entro i limiti desiderati. Tuttavia, se tutti i finanziamenti previsti per i Paesi in via di sviluppo saranno correttamente destinati, ci si potrà incamminare verso una significativa azione di controllo del riscaldamento globale.
Come ampiamente previsto da molti analisti, la Quindicesima Conferenza delle Parti (COP15), tenutasi a Copenhagen dal 7 al 18 dicembre 2009, non si è conclusa con la firma di un trattato internazionale legalmente vincolate in grado di sostituire il Protocollo di Kyoto al momento della sua naturale scadenza nel 2012.
Difficilmente l’esito della COP15 poteva essere diverso. Chi riponeva speranze sulla possibilità di firmare un accordo internazionale vincolante non faceva i conti con la realtà dei fatti. Innanzitutto, sarebbe stato impossibile per gli Stati Uniti impegnarsi senza il voto preventivo del Senato sulla proposta di legge Boxer-Kerry, contenente obiettivi domestici per la riduzione delle emissioni. L’approvazione da parte del Senato della Boxer-Kerry si aggiungerebbe all’American Clean Energy and Security Act (la legge Waxman-Markey), già passato al Congresso, e darebbe al Presidente Obama la possibilità, e la credibilità, di proporre una più ambiziosa politica climatica a livello internazionale.
In secondo luogo, se i Paesi in via di sviluppo a rapida crescita non faranno alcuno sforzo per ridurre le loro emissioni di gas serra – non necessariamente da subito, più realisticamente dopo un periodo di grazia – ogni sforzo dei Paesi sviluppati nel frenare le loro emissioni sarebbe vanificato e diventerebbe impossibile contenere l’aumento della temperature entro livelli accettabili.
I Paesi in via di sviluppo rifiutano di assumere impegni di riduzione delle emissioni legalmente vincolanti perché il loro obiettivo principale è la lotta contro la povertà e perché, storicamente, essi sono solo marginalmente responsabili dello stock di gas serra presenti nell’atmosfera. Il loro rifiuto è quindi perfettamente comprensibile.
Queste sono, in breve, le cause principali dello stallo nelle negoziazioni. A Copenhagen è stato impossibile far nascere un vero e proprio trattato internazionale e i leader mondiali, la mattina di sabato 19 dicembre, hanno potuto solo prendere atto di un più modesto Accordo di Copenhagen.
Ci sono però due novità interessanti, sulle quali è opportuno riflettere prima di esprimere un giudizio sull’esito della COP15: 1 i leader delle maggiori economie hanno indicato, sebbene in maniera informale e non vincolante, obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020; 2 a Copenhagen è stato definito l’ammontare delle risorse che dovranno essere destinate ai Paesi in via di sviluppo per finanziare azioni di mitigazione, come viene definita in gergo l’azione di abbattimento delle emissioni, e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Efficacia e coerenza dell’Accordo di Copenhagen
Iniziamo con l’esaminare se le riduzioni delle emissioni annunciate a Copenhagen siano o meno coerenti con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo.
La Tabella 1 raccoglie gli obiettivi annunciati dalle maggiori economie mondiali a Copenhagen. Purtroppo, l’Appendice I all’Accordo di Copenhagen, che dovrebbe contenere i tagli alle emissioni previsti in ogni Paese, è stato distribuito vuoto nella versione ufficiale dell’Accordo distribuita dallo UNFCCC. Noi abbiamo ricostruito gli obiettivi usando diverse fonti, inclusa una copia non ufficiale dell’Appendice I, e li abbiamo omogeneizzati esprimendoli come variazione delle emissioni rispetto al 1990. Per quei Paesi che hanno usato come riferimento il loro scenario di Business-as-Usual (BaU), abbiamo usato lo scenario BaU del modello WITCH per calcolare le emissioni al 2020. Cina ed India hanno annunciato di voler ridurre la quantità di emissioni di CO2 per unità di prodotto interno lordo (Pil), la prima del 45%, la seconda del 20-25% rispetto al 2005. Entrambi questi obiettivi sembrano essere raggiungibili già nello scenario BaU del modello WITCH, il quale prevede una riduzione autonoma delle emissioni di CO2 per unità di Pil del 53% in Cina e del 42% in India. Anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia, nel suo World Energy Outlook 2009 (WEO 2009), prevede che nel 2020 la Cina ridurrà le emissioni di CO2 per unità di Pil del 45% e l’India del 38%, in uno scenario BaU. Pertanto, sia per la Cina, sia per l’India, abbiamo sostituito gli obiettivi annunciati a Copenhagen con le loro emissioni di tutti i gas serra dello scenario BaU del modello WITCH.
Tabella 1. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Copenhagen.
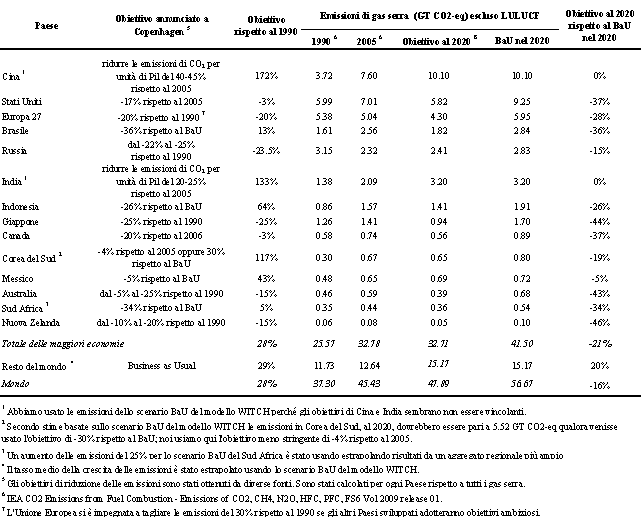
Gli impegni presi a Copenhagen dalle maggiori economie mondiali per il 2020, se confermati, implicherebbero un aumento complessivo delle emissioni di gas serra del 28% rispetto al 1990. Se confrontiamo il livello delle emissioni al 2020 con quello che si avrebbe in uno scenario BaU, nello stesso anno, le emissioni si ridurrebbero del 21%. Se assumiamo che il resto del mondo continui ad emettere gas serra come in uno scenario BaU, le emissioni globali aumenterebbero fino a raggiungere 48 GT CO2-eq al 2020. Ciò rappresenterebbe un aumento del 29% rispetto al 1990, un aumento del 5% rispetto al 2005 ed una riduzione del 16% rispetto al livello di emissioni dello scenario BaU.
Sarà sufficiente questo impegno per ridurre in maniera adeguata il riscaldamento globale? Come termine di paragone possiamo usare gli scenari del Fourth Assessment Report dell’IPCC. Essi mostrano che, per limitare l’aumento della temperatura a 2.0-2.4 °C alla fine del secolo, le emissioni di CO2 devono raggiungere il massimo entro il 2015, decrescere di circa il 5-10% nel 2020 e poi continuare una rapida discesa fino quasi a scomparire. Se, invece, il picco delle emissioni avverrà solo entro il 2020, l’aumento della temperatura sarà di circa 2.4-2.8 °C.3 Pertanto, sebbene la riduzione delle emissioni globali del 16% rispetto ad uno scenario BaU non sia affatto trascurabile, i tagli alle emissioni proposti a Copenhagen saranno chiaramente insufficienti per contenere l’aumento della temperatura entro i 2°C.
La prima novità che ci giunge da Copenhagen è quindi che i tagli delle emissioni proposti non sono coerenti con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura entro i 2°C, obiettivo dichiarato nello stesso Accordo di Copenhagen.4
Passiamo ora ad esaminare la seconda novità di Copenhagen, la costituzione di un fondo internazionale per finanziare in maniera adeguata la mitigazione e l’adattamento nei Paesi in via di sviluppo.
Sono sufficienti i fondi stanziati nell’Accordo di Copenhagen?
Nell’Accordo di Copenhagen si menziona esplicitamente la necessità di stabilire rapidamente un fondo che ammonterà a 10 miliardi di dollari ogni anno, dal 2010 al 2012 (per un totale di 30 miliardi di dollari). Nel caso in cui ci sia un’azione di mitigazione sufficientemente elevata e trasparente, i Paesi sviluppati si impegnano a mobilizzare, congiuntamente, 100 miliardi di dollari ogni anno, dal 2013 al 2020. I finanziamenti proverranno da fonti pubbliche e private, bilaterali e multilaterali, incluse forme alternative di finanziamento. Una porzione significativa di questi fondi verrà erogata mediante il Copenhagen Green Climate Fund (CGCF), istituito proprio dall’Accordo di Copenhagen.
L’efficacia del CGCF dipenderà in gran parte da come i fondi saranno divisi fra investimenti per la mitigazione e investimenti per l’adattamento, cosa ancora non ben definita nell’Accordo. Sebbene sia necessario investire sia in mitigazione, sia in adattamento, la distribuzione ottimale degli investimenti nel tempo, divisa fra le due aree d’intervento, non è la stessa. Uno studio recente, basato su una versione estesa del modello WITCH sviluppata per studiare la distribuzione temporale degli investimenti in mitigazione e adattamento, mostra chiaramente che, mentre sarebbe ottimale investire immediatamente nella riduzione delle emissioni, la maggior parte degli investimenti per l’adattamento dovrebbe essere rinviata nel tempo.5
Questa distribuzione temporale si spiega con il fatto che, mentre è imperativo ridurre le emissioni di gas serra il prima possibile per conservare la possibilità di raggiungere livelli di temperatura bassi, gli impatti dei cambiamenti climatici nel breve periodo saranno modesti. Le misure di adattamento possono essere realizzate più avanti, in tempi relativamente brevi, quando i cambiamenti climatici saranno potenzialmente molto più dannosi di oggi.
Tabella 2. Il potenziale di mitigazione del Copenhagen Green Climate Fund.
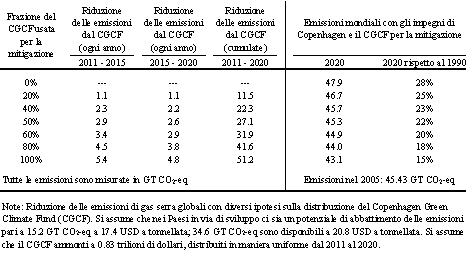
Supponiamo, quindi, che le risorse che i Paesi sviluppati si sono impegnati a mobilizzare a Copenhagen siano usate in prevalenza per finanziare progetti per la riduzione delle emissioni di gas serra, dal 2011 al 2020. Supponiamo, altresì, che questi progetti producano riduzioni delle emissioni addizionali rispetto agli obiettivi annunciati dai Paesi sviluppati e che si aggiungano quindi ad ogni eventuale credito risultante dai Clean Development Mechanisms (CDMs) finanziati per rispettare questi impegni. Saranno queste risorse sufficienti per finanziare la ristrutturazione dei sistemi energetici, ridurre la deforestazione, migliorare le pratiche agricole e di gestione dei suoli nei Paesi in via di sviluppo, in modo da colmare il divario che esiste fra gli impegni presi e le traiettorie di riduzione delle emissioni necessarie per limitare il riscaldamento globale entro livelli sicuri?
Le nostre stime, ottenute sempre usando il modello WITCH, mostrano che se il 60% del CGCF sarà destinato a finanziare la mitigazione nei Paesi in via di Sviluppo, le emissioni potrebbero effettivamente raggiungere un massimo al 2020, come mostrato in Tabella 2.6 Con circa 50 miliardi di dollari ogni anno, dal 2011 al 2020, si potrebbero ridurre le emissioni di circa 2.9 GT CO2-eq l’anno fra il 2011 e il 2015 e di circa 2.5 GT CO2-eq dal 2016 al 2020, per un totale di 27 GT CO2-eq.7 Questo schema di finanziamento sarà però insufficiente per raggiungere il massimo delle emissioni globali entro il 2015. La riduzione delle emissioni sarebbe ragguardevole rispetto al BaU, ma l’azione di abbattimento non raggiungerebbe l’intensità necessaria a rendere possibile il raggiungimento dell’obiettivo dei 2°C.
Se il CGCF fosse trasformato interamente in un fondo per la mitigazione (100% dei fondi per l’abbattimento delle emissioni), le emissioni globali potrebbero, nel 2020, essere inferiori del 3% rispetto al 2005, l’aumento, rispetto al 1990, potrebbe essere contenuto al 18% e si otterrebbe una riduzione del 22% rispetto al BaU. Con un’azione di mitigazione rapida ed efficiente, si potrebbe quindi raggiungere il massimo delle emissioni intorno al 2015, ma per collocarsi poi sulla traiettoria ottimale delle emissioni per il 2020 (circa -5% -10% rispetto al 2005), sarebbero necessari ulteriori finanziamenti dal 2015 al 2020. Una rappresentazione grafica del potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra di un CGCF orientato esclusivamente alla mitigazione è data in Figura 1.
Figura 1. Livello storico delle emissioni, scenario BaU, obiettivi di Copenhagen e il ruolo del CGCF per la mitigazione.
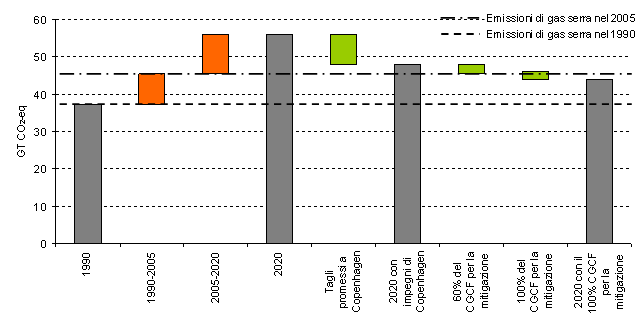
Conclusioni
Una prima analisi degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per l’anno 2020 annunciati informalmente a Copenhagen mostra che essi potrebbero abbattere le emissioni rispetto allo scenario BaU in maniera non trascurabile, ma non si sarebbe in grado di scendere al di sotto del livello del 2005. Raggiungere un massimo delle emissioni fra ora e il 2020 è invece una condizione necessaria per contenere il riscaldamento globale entro livelli sicuri. Gli scenari che abbiamo prodotto lasciano intendere che le emissioni di gas serra continueranno a crescere, anche qualora gli impegni di Copenhagen venissero rispettati, e le concentrazioni nell’atmosfera supereranno facilmente i 450 ppm CO2-eq nel 2020, soglia oltre la quale sarà quasi impossibile contenere l’aumento della temperatura entro i 2°C.
Sarà pertanto necessario investire il più possibile nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie a basse emissioni, aumentare l’efficienza energetica, ridurre la deforestazione, realizzare progetti per la cattura e lo stoccaggio geologico delle emissioni, etc. Se tutti i fondi previsti dal CGCF saranno usati per finanziare azioni di mitigazione a basso costo, addizionali, nei Paesi in via di sviluppo, sarà possibile ridurre le emissioni del 2020 sotto il livello del 2005. Con una continua azione di mitigazione nei decenni successivi, sarà allora possibile limitare l’aumento della temperatura realisticamente non al di sotto dei 2°C, ma entro livelli sufficientemente bassi.
Le novità che ci giungono da Copenhagen sono quindi più sfaccettate di quanto apparirebbe ad una prima analisi. I tagli annunciati alle emissioni di gas serra non sono affatto sufficienti per controllare il riscaldamento globale entro i limiti desiderati. Tuttavia, se tutti i finanziamenti previsti per i Paesi in via di sviluppo saranno destinati a finanziare la mitigazione, ci si potrà incamminare verso una significativa azione di controllo del riscaldamento globale. Sarà cruciale, pertanto, che nella prossima fase delle negoziazioni si presti molta attenzione a come usare il Copenhagen Green Climate Fund.
Emanuele Massetti
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC).
Carlo Carraro
Professore Ordinario di Econometria presso l’Università Cà Foscari di Venezia
Membro dell’IPCC (Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici)
Premio Nobel per la pace 2007
